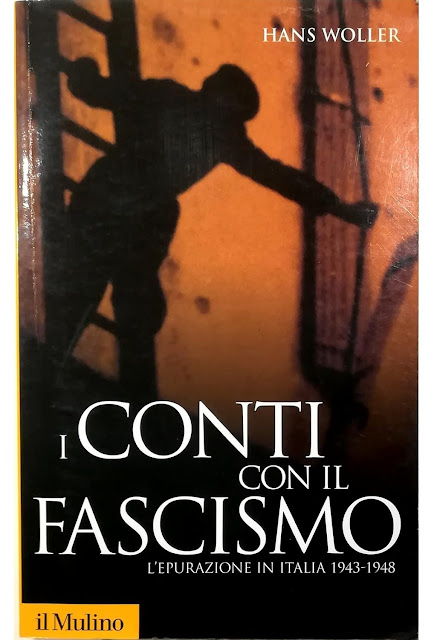Nelle aule di giustizia di Venezia. Le prime udienze “arroventate” <412
Come in altre CAS l’inaugurazione dei processi fu attesa dalla popolazione fremente «tra ansia di giustizia e desiderio di vendetta» <413, e come in altre realtà anche a Venezia il numero di cittadini accorsi per assistere fu esorbitante. L’occasione di essere testimoni alla condanna di un collaborazionista, di un assassino, di un aguzzino costituiva un evento che nessuno si voleva perdere, soprattutto se, come accadde in particolar modo nei primi mesi, le sentenze non così raramente finivano per decretare la pena capitale o decine d’anni di carcere <414. Il “fascista alla sbarra” era diventato un interesse comunitario che assorbiva l’attenzione di tutti. Essendo le udienze pubbliche <415, in migliaia si ammassavano fuori dal tribunale fin dalle prime ore del mattino, pertanto si ripropose anche qui, come in moltissime altre sedi italiane, la necessità di istallare degli altoparlanti fuori dal tribunale, per alleggerire la pressione della folla e non da ultimo per motivi di sicurezza. L’aula veniva aperta un’ora prima del dibattimento <416 (probabilmente verso le ore otto, considerando che moltissimi fascicoli processuali presentano l’annotazione dell’inizio del processo sulle nove/nove e quindici <417) e il flusso veniva regolato da uno speciale servizio d’ordine. «I diffusori trasformarono così i primi processi in pubbliche requisitorie», ai «limiti della spettacolarizzazione» <418. In più la sede della CAS posta nel cuore della città a Rialto, nelle vicinanze del frequentatissimo mercato, non fece che attirare in gran numero anche diversi passanti incuriositi. Di norma il procedimento si svolgeva con una procedura piuttosto rapida. Questo era dovuto a molteplici fattori: prima di tutto all’art. 13 del decreto legislativo n. 142 che dimezzava i tempi dell’istruttoria e del giudizio <419, in secondo luogo ai tempi molto contingentati delle CAS (più volte ricordato, 6 mesi), al numero di processi piuttosto elevato ed infine alle aspettative della cittadinanza, ansiosa di udire sentenze adeguate. All’inizio del dibattimento il presidente della Corte dava lettura dei capi d’accusa per la lasciare poi la parola agli imputati. Seguivano successivamente gli interrogatori dei testimoni a carico e “discarico” <420, la requisitoria del pm e l’arringa dell’avvocato. Al termine di questa fase il presidente e i quattro giudici popolari si ritiravano in camera di consiglio per discutere ed emettere la sentenza <421. È interessante notare, consultando i numerosi fascicoli processuali, che ognuno di essi contiene un semplice foglietto di annotazioni scritte dal presidente, frutto della discussione con i colleghi proprio in camera di consiglio, le quali rappresentano la sentenza ufficiosa (non ancora verbalizzata) pronunciata attraverso i diversi articoli dei codici e dei decreti422. Come rammenta Borghi, seguendo questa procedura il ritmo dei processi fu così spedito da permettere di celebrare più processi al giorno <423. Ad esempio si segnala come le carte del verbale del dibattimento nel processo a Giovanni Berlese, celebrato il 15 giugno ’45, confermino questa tesi: aperto alle 9, il processo venne chiuso appena un’ora dopo, alle 10. La sentenza, per nulla mite, lo condannò a 24 anni di reclusione424 (e «all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, all’interdizione legale per la durata della pena, alla libertà vigilata per tempo non inferiore a tre anni [ed] alle spese processuali» <425). Questo dibattimento venne ampiamente superato, in quanto a rapidità dell'udienza, da altri processi che videro però sul banco degli imputati collaborazionisti di minor peso; il dibattimento intero contro Edoardo Frignoli durò appena poco più di mezz’ora <426.
In queste prime udienze il popolo rivestì un ruolo da protagonista. Del resto il rinvio a giudizio dei persecutori che avevano terrorizzato la città e la provincia fino a qualche settimana prima rappresentò una vera e propria attrazione per la folla che partecipò tutt’altro che passivamente alle udienze: urla, fischi, cori e applausi fecero da sottofondo a parecchi dibattimenti <427. Tra questi, alcuni vennero persino interrotti per un eccessivo fermento dei presenti in aula; un rischio inoltre era rappresentato dalla possibilità che la gente si impossessasse dell’imputato per linciarlo e sfogare la propria sete di vendetta. «La presenza, numerosa e rumorosa, della popolazione [divenne] perlomeno fino al declinare del 1945, parte integrante nella rappresentazione dell’aula di giustizia» <428. La stessa stampa quotidiana riportava non solo la sentenza del processo bensì il comportamento del pubblico. Alcune proteste furono così veementi da influenzare il processo stesso, la sentenza e la possibilità della difesa di condurre arringhe efficaci. L’avvocato Carlo Buttero, veneziano e difensore dell’imputata Clementina Pomarici Santoni <429 chiese alla Corte che si tenesse conto, nel pronunciare la sentenza di Cassazione, dell’«ambiente arroventato e pericoloso in cui ebbe a svolgersi il processo» <430 della CAS lagunare. Tale processo, come ancora l’avvocato sottolineò, essendo il terzo celebrato dalla Corte d’Assise straordinaria di Venezia «dopo la Liberazione» risentì fortemente del «furore di popolo che a tutti i costi voleva sangue e condanne gravissime» e così facendo «tolse […] alla difesa la sicurezza e la serenità necessarie per l’adempimento del proprio mandato, sia pure d’ufficio» <431. Simili le affermazioni di un altro avvocato, il romano Mario Pittaluga, che nella difesa stilata per la Cassazione in difesa al suo assistito Gino Carrer <432 (brigatista nero condannato a morte con sentenza pronunciata dalla CAS di Venezia il 26 settembre 1945) scriveva che il verdetto della Corte d’Assise avesse risentito «della arroventata atmosfera in cui il processo si [era] celebrato, ed [era] priv[o] di ogni obiettività e serenità» <433. D’altra parte l’affluenza dei cittadini era stata fortemente condizionata dai quotidiani locali che avevano cominciato a pubblicizzare l’inizio dei lavori delle CAS attraverso numerosi articoli a titoli cubitali nelle prime pagine, con un’intensità che mancava da anni in seguito alle censure del regime. In questo i giornali diretti dagli organi del CLN descrissero l’imminente avvio della giustizia con toni risolutivi e manifestando la convinzione che le corti avrebbero fatto inflessibilmente giustizia <434.
[NOTE]
412 La definizione è presente nella difesa stilata per la Corte di Cassazione dall’avv. Carlo Buttero, legale di Clementina Pomarici Santoni, ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 1, fascicolo 8, anno 1945, imputato Clementina Pomarici Santoni. Il concetto viene ribadito dalla storiografia generale che descrive le prime udienze come “incandescenti”. La Pomarici era stata nel Ventennio fiduciaria delle organizzazioni femminili del Partito fascista e in seguito aveva aderito alla RSI.
413 T. ROVATTI, Ansia di giustizia e desiderio di vendetta. Esperienze di punizione nell’Italia del Centro-nord, 1945-1946, in E. ACCIAI, G. PANVINI, C. POESIO, T. ROVATTI, (a cura di), Oltre il 1945. Violenza, conflitto sociale e ordine pubblico nel dopoguerra europeo, Viella, Roma, 2017, pp. 73-87.
414 A tal proposito di vedano le prime sentenze della CAS veneziana.
415 Gli unici ad essere esclusi erano coloro che non avevano compiuto i 18 anni. M. DONDI, La lunga liberazione, op. cit., pp. 49-55.
416 Cfr. M. BORGHI, Dall’insurrezione alla smobilitazione, op. cit., p. 61.
417 Si vedano ad esempio i verbali del dibattimento degli importanti processi contro Umberto Pepi e Pio Leoni, ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 1, fascicolo 3, anni 1945, imputato Umberto Pepi e ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 1, fascicolo 19, anno 1945, imputato Pio Leoni.
418 Cfr. M. BORGHI, Dall’insurrezione alla smobilitazione, op. cit., pp. 61-62.
419 Si veda decreto legge luogotenenziale n. 142, 22 aprile 1945, art. 13 e supra, capitolo primo, scena quinta, paragrafo secondo: Alcune problematiche del decreto.
420 È questa la parola che si trova in numerosi processi. Cfr. ASVe, sezione CAS Venezia.
421 Si consulti ad esempio il fascicolo processuale dell’imputato Giovanni Berlese, che contiene una chiara sequenza di queste fasi attraverso i documenti ben ordinati, ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 1, fascicolo 11, anno 1945, imputato Giovanni Berlese. In aggiunta si rimanda per ulteriori informazioni a M. BORGHI, Dall’insurrezione alla smobilitazione, op. cit., p. 62.
422 Sono citati: il decreto legge luogotenenziale n. 159 del 27 luglio 1944, il decreto legge luogotenenziale n. 142, 22 aprile 1945, il Codice Penale militare di guerra e il Codice penale (Codice Rocco).
423 Cfr. M. BORGHI, Dall’insurrezione alla smobilitazione, op. cit., p. 62.
424 ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 1, fascicolo 11, anno 1945, cit. D’altra parte pur essendo poco mite la sentenza della CAS veneziana, poi confermata dalla Cassazione, il condannato beneficiò dell’amnistia Togliatti e venne scarcerato. Questa informazione è reperibile grazie al primo documento del fascicolo ma ultimo in ordine cronologico, datato 3 luglio 1946.
425 Ivi, documento numero 21.
426 ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 3, fascicolo 76, anno 1945, imputato Edoardo Frignoli.
427 Si vedano, tra i tanti, il caso Basile descritto in L. BORDONI, La sentenza Basile e il dibattito sul funzionamento delle Corti d’assise straordinarie lombarde, in C. NUBOLA, P. PEZZINO, T. ROVATTI, (a cura di), Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d’assise e nei tribunali militari, Il Mulino, Bologna, 2019, pp. 57-69 e H. WOLLER, I conti con il fascismo, op. cit., pp. 410-423.
428 M. BORGHI, Dall’insurrezione alla smobilitazione, op. cit., p. 63.
429 Per una breve analisi del processo alla Pomarici Santoni si veda sotto: “scena quarta”.
430 ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 1, fascicolo 8, anno 1945, cit.
431 Ibidem. Il documento è datato 11 gennaio 1946, e precede cronologicamente un atto che riporta la sentenza della Cassazione datata 24 giugno dello stesso anno (con udienza avvenuta il 17 aprile).
432 ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 3, fascicoli 87-88, anno 1945, cit.
433 Ivi, difesa per la Corte di Cassazione dell’avv. Mario Pittaluga, datato 31 gennaio 1946. Woller sostiene che in talune occasioni la pressione popolare in aula fu così forte da non permettere alla difesa di pronunciarsi. A questi avvocati, sostiene l’autore, non rimase che presentare solamente una difesa in forma scritta. Vedi H. WOLLER, I conti con il fascismo, op. cit., p. 413.
434 Si veda M. DONDI, La lunga liberazione, op. cit., pp. 49-55.
Mauro Luciano Malo, La giustizia di transizione tra fascismo e democrazia. La Corte d’Assise straordinaria e l’amnistia Togliatti a Venezia (1945-1947), Tesi di laurea, Università Ca' Foscari - Venezia, Anno Accademico 2019-2020
Come in altre CAS l’inaugurazione dei processi fu attesa dalla popolazione fremente «tra ansia di giustizia e desiderio di vendetta» <413, e come in altre realtà anche a Venezia il numero di cittadini accorsi per assistere fu esorbitante. L’occasione di essere testimoni alla condanna di un collaborazionista, di un assassino, di un aguzzino costituiva un evento che nessuno si voleva perdere, soprattutto se, come accadde in particolar modo nei primi mesi, le sentenze non così raramente finivano per decretare la pena capitale o decine d’anni di carcere <414. Il “fascista alla sbarra” era diventato un interesse comunitario che assorbiva l’attenzione di tutti. Essendo le udienze pubbliche <415, in migliaia si ammassavano fuori dal tribunale fin dalle prime ore del mattino, pertanto si ripropose anche qui, come in moltissime altre sedi italiane, la necessità di istallare degli altoparlanti fuori dal tribunale, per alleggerire la pressione della folla e non da ultimo per motivi di sicurezza. L’aula veniva aperta un’ora prima del dibattimento <416 (probabilmente verso le ore otto, considerando che moltissimi fascicoli processuali presentano l’annotazione dell’inizio del processo sulle nove/nove e quindici <417) e il flusso veniva regolato da uno speciale servizio d’ordine. «I diffusori trasformarono così i primi processi in pubbliche requisitorie», ai «limiti della spettacolarizzazione» <418. In più la sede della CAS posta nel cuore della città a Rialto, nelle vicinanze del frequentatissimo mercato, non fece che attirare in gran numero anche diversi passanti incuriositi. Di norma il procedimento si svolgeva con una procedura piuttosto rapida. Questo era dovuto a molteplici fattori: prima di tutto all’art. 13 del decreto legislativo n. 142 che dimezzava i tempi dell’istruttoria e del giudizio <419, in secondo luogo ai tempi molto contingentati delle CAS (più volte ricordato, 6 mesi), al numero di processi piuttosto elevato ed infine alle aspettative della cittadinanza, ansiosa di udire sentenze adeguate. All’inizio del dibattimento il presidente della Corte dava lettura dei capi d’accusa per la lasciare poi la parola agli imputati. Seguivano successivamente gli interrogatori dei testimoni a carico e “discarico” <420, la requisitoria del pm e l’arringa dell’avvocato. Al termine di questa fase il presidente e i quattro giudici popolari si ritiravano in camera di consiglio per discutere ed emettere la sentenza <421. È interessante notare, consultando i numerosi fascicoli processuali, che ognuno di essi contiene un semplice foglietto di annotazioni scritte dal presidente, frutto della discussione con i colleghi proprio in camera di consiglio, le quali rappresentano la sentenza ufficiosa (non ancora verbalizzata) pronunciata attraverso i diversi articoli dei codici e dei decreti422. Come rammenta Borghi, seguendo questa procedura il ritmo dei processi fu così spedito da permettere di celebrare più processi al giorno <423. Ad esempio si segnala come le carte del verbale del dibattimento nel processo a Giovanni Berlese, celebrato il 15 giugno ’45, confermino questa tesi: aperto alle 9, il processo venne chiuso appena un’ora dopo, alle 10. La sentenza, per nulla mite, lo condannò a 24 anni di reclusione424 (e «all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, all’interdizione legale per la durata della pena, alla libertà vigilata per tempo non inferiore a tre anni [ed] alle spese processuali» <425). Questo dibattimento venne ampiamente superato, in quanto a rapidità dell'udienza, da altri processi che videro però sul banco degli imputati collaborazionisti di minor peso; il dibattimento intero contro Edoardo Frignoli durò appena poco più di mezz’ora <426.
In queste prime udienze il popolo rivestì un ruolo da protagonista. Del resto il rinvio a giudizio dei persecutori che avevano terrorizzato la città e la provincia fino a qualche settimana prima rappresentò una vera e propria attrazione per la folla che partecipò tutt’altro che passivamente alle udienze: urla, fischi, cori e applausi fecero da sottofondo a parecchi dibattimenti <427. Tra questi, alcuni vennero persino interrotti per un eccessivo fermento dei presenti in aula; un rischio inoltre era rappresentato dalla possibilità che la gente si impossessasse dell’imputato per linciarlo e sfogare la propria sete di vendetta. «La presenza, numerosa e rumorosa, della popolazione [divenne] perlomeno fino al declinare del 1945, parte integrante nella rappresentazione dell’aula di giustizia» <428. La stessa stampa quotidiana riportava non solo la sentenza del processo bensì il comportamento del pubblico. Alcune proteste furono così veementi da influenzare il processo stesso, la sentenza e la possibilità della difesa di condurre arringhe efficaci. L’avvocato Carlo Buttero, veneziano e difensore dell’imputata Clementina Pomarici Santoni <429 chiese alla Corte che si tenesse conto, nel pronunciare la sentenza di Cassazione, dell’«ambiente arroventato e pericoloso in cui ebbe a svolgersi il processo» <430 della CAS lagunare. Tale processo, come ancora l’avvocato sottolineò, essendo il terzo celebrato dalla Corte d’Assise straordinaria di Venezia «dopo la Liberazione» risentì fortemente del «furore di popolo che a tutti i costi voleva sangue e condanne gravissime» e così facendo «tolse […] alla difesa la sicurezza e la serenità necessarie per l’adempimento del proprio mandato, sia pure d’ufficio» <431. Simili le affermazioni di un altro avvocato, il romano Mario Pittaluga, che nella difesa stilata per la Cassazione in difesa al suo assistito Gino Carrer <432 (brigatista nero condannato a morte con sentenza pronunciata dalla CAS di Venezia il 26 settembre 1945) scriveva che il verdetto della Corte d’Assise avesse risentito «della arroventata atmosfera in cui il processo si [era] celebrato, ed [era] priv[o] di ogni obiettività e serenità» <433. D’altra parte l’affluenza dei cittadini era stata fortemente condizionata dai quotidiani locali che avevano cominciato a pubblicizzare l’inizio dei lavori delle CAS attraverso numerosi articoli a titoli cubitali nelle prime pagine, con un’intensità che mancava da anni in seguito alle censure del regime. In questo i giornali diretti dagli organi del CLN descrissero l’imminente avvio della giustizia con toni risolutivi e manifestando la convinzione che le corti avrebbero fatto inflessibilmente giustizia <434.
[NOTE]
412 La definizione è presente nella difesa stilata per la Corte di Cassazione dall’avv. Carlo Buttero, legale di Clementina Pomarici Santoni, ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 1, fascicolo 8, anno 1945, imputato Clementina Pomarici Santoni. Il concetto viene ribadito dalla storiografia generale che descrive le prime udienze come “incandescenti”. La Pomarici era stata nel Ventennio fiduciaria delle organizzazioni femminili del Partito fascista e in seguito aveva aderito alla RSI.
413 T. ROVATTI, Ansia di giustizia e desiderio di vendetta. Esperienze di punizione nell’Italia del Centro-nord, 1945-1946, in E. ACCIAI, G. PANVINI, C. POESIO, T. ROVATTI, (a cura di), Oltre il 1945. Violenza, conflitto sociale e ordine pubblico nel dopoguerra europeo, Viella, Roma, 2017, pp. 73-87.
414 A tal proposito di vedano le prime sentenze della CAS veneziana.
415 Gli unici ad essere esclusi erano coloro che non avevano compiuto i 18 anni. M. DONDI, La lunga liberazione, op. cit., pp. 49-55.
416 Cfr. M. BORGHI, Dall’insurrezione alla smobilitazione, op. cit., p. 61.
417 Si vedano ad esempio i verbali del dibattimento degli importanti processi contro Umberto Pepi e Pio Leoni, ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 1, fascicolo 3, anni 1945, imputato Umberto Pepi e ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 1, fascicolo 19, anno 1945, imputato Pio Leoni.
418 Cfr. M. BORGHI, Dall’insurrezione alla smobilitazione, op. cit., pp. 61-62.
419 Si veda decreto legge luogotenenziale n. 142, 22 aprile 1945, art. 13 e supra, capitolo primo, scena quinta, paragrafo secondo: Alcune problematiche del decreto.
420 È questa la parola che si trova in numerosi processi. Cfr. ASVe, sezione CAS Venezia.
421 Si consulti ad esempio il fascicolo processuale dell’imputato Giovanni Berlese, che contiene una chiara sequenza di queste fasi attraverso i documenti ben ordinati, ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 1, fascicolo 11, anno 1945, imputato Giovanni Berlese. In aggiunta si rimanda per ulteriori informazioni a M. BORGHI, Dall’insurrezione alla smobilitazione, op. cit., p. 62.
422 Sono citati: il decreto legge luogotenenziale n. 159 del 27 luglio 1944, il decreto legge luogotenenziale n. 142, 22 aprile 1945, il Codice Penale militare di guerra e il Codice penale (Codice Rocco).
423 Cfr. M. BORGHI, Dall’insurrezione alla smobilitazione, op. cit., p. 62.
424 ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 1, fascicolo 11, anno 1945, cit. D’altra parte pur essendo poco mite la sentenza della CAS veneziana, poi confermata dalla Cassazione, il condannato beneficiò dell’amnistia Togliatti e venne scarcerato. Questa informazione è reperibile grazie al primo documento del fascicolo ma ultimo in ordine cronologico, datato 3 luglio 1946.
425 Ivi, documento numero 21.
426 ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 3, fascicolo 76, anno 1945, imputato Edoardo Frignoli.
427 Si vedano, tra i tanti, il caso Basile descritto in L. BORDONI, La sentenza Basile e il dibattito sul funzionamento delle Corti d’assise straordinarie lombarde, in C. NUBOLA, P. PEZZINO, T. ROVATTI, (a cura di), Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia. I processi presso le Corti d’assise e nei tribunali militari, Il Mulino, Bologna, 2019, pp. 57-69 e H. WOLLER, I conti con il fascismo, op. cit., pp. 410-423.
428 M. BORGHI, Dall’insurrezione alla smobilitazione, op. cit., p. 63.
429 Per una breve analisi del processo alla Pomarici Santoni si veda sotto: “scena quarta”.
430 ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 1, fascicolo 8, anno 1945, cit.
431 Ibidem. Il documento è datato 11 gennaio 1946, e precede cronologicamente un atto che riporta la sentenza della Cassazione datata 24 giugno dello stesso anno (con udienza avvenuta il 17 aprile).
432 ASVe, sezione CAS Venezia, busta numero 3, fascicoli 87-88, anno 1945, cit.
433 Ivi, difesa per la Corte di Cassazione dell’avv. Mario Pittaluga, datato 31 gennaio 1946. Woller sostiene che in talune occasioni la pressione popolare in aula fu così forte da non permettere alla difesa di pronunciarsi. A questi avvocati, sostiene l’autore, non rimase che presentare solamente una difesa in forma scritta. Vedi H. WOLLER, I conti con il fascismo, op. cit., p. 413.
434 Si veda M. DONDI, La lunga liberazione, op. cit., pp. 49-55.
Mauro Luciano Malo, La giustizia di transizione tra fascismo e democrazia. La Corte d’Assise straordinaria e l’amnistia Togliatti a Venezia (1945-1947), Tesi di laurea, Università Ca' Foscari - Venezia, Anno Accademico 2019-2020