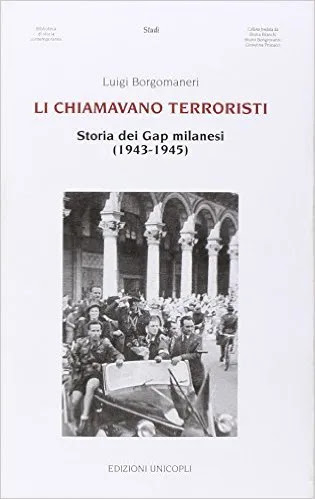Racconta un dirigente di Reggio Emilia, ex-partigiano: "Il fatto era che non le conoscevamo queste compagne. Cioè non conoscevamo le loro peculiari capacità… Come facevamo a conoscerle? Beh, tutt’al più la conoscenza che avevamo era limitata alle compagne che erano state staffette. Ma far la staffetta non significava mettere in mostra delle particolari doti politiche. Significava avere due buone gambe per far girare il rapporto della bicicletta e il coraggio di affrontare, oltre allo sforzo fisico anche lo stress spirituale… Noi conoscevamo molte compagne che avevano queste doti, ma le loro capacità politiche…". <2
Se potessi realizzare il mio desiderio di sovrapporre i nomi delle donne che diedero vita all’UDI [Unione Donne Italiane], vedremmo che coincidono (come gli obiettivi politici) quasi perfettamente con quelli dei GDD [Gruppi Difesa Donna, organismi della Resistenza], ma sono molto più numerosi. Sono tante di più le donne che si mobilitano. E, con ragione, si potrebbe pensare che si tratti delle donne dei Gruppi che, pur non essendosi registrate come partigiane, escono allo scoperto e a una cittadinanza attiva proprio per l’esperienza della Resistenza che le aveva temprate all’impegno politico e sociale mentre erano convinte di fare solo il loro dovere, o quello che qualcuna ha definito "fare quello che era nell’ordine naturale delle cose" per opporsi alla guerra e ai nazifascisti? La mostra di Ravenna prova a documentare qualcosa su quante di più erano rispetto a quelle riconosciute. Ma in questi anni ne stiamo scoprendo sempre altre, molte altre!
L’UDI è il soggetto politico che ha raccolto l’eredità di queste donne e ha svolto un ruolo centrale nel cambiamento, ammodernamento e progresso del nostro Paese. Abbiamo celebrato con orgoglio il 70° perché sono stati settant’anni di lavoro proficuo che ha dato molti risultati, anche se oggi siamo di fronte a una situazione in cui molte conquiste sono sotto attacco.
Proprio settant’anni fa si svolse a Firenze, al Teatro della Pergola, tra il 20 e il 23 ottobre 1945, il Congresso che diede vita all’Unione Donne Italiane: in esso si unificarono i circoli sorti a partire dal 1944, dopo la Liberazione di Roma, nell’Italia liberata e i Gruppi di Difesa delle Donna, che avevano organizzato le donne a sostegno della Resistenza nell’Italia occupata. Quel 1° Congresso Nazionale dell’UDI - congresso "costitutivo" - adottò il programma, approvò lo Statuto ed elesse democraticamente le dirigenti. Quel Congresso sanciva che l’UDI era nata dall’incontro dei movimenti femminili dei partiti del CLN, esclusa la Democrazia Cristiana che, pur avendo fatto parte dei GDD, non aveva aderito al Comitato di Iniziativa sorto nel 1944 nell’Italia liberata. In verità, tra le firmatarie dell’appello del Comitato di Iniziativa, figuravano anche rappresentanti della società civile che, in varie forme, erano donne socialmente e politicamente impegnate nei partiti del CLN. Al Congresso erano presenti delegazioni estere (americane, inglesi, cecoslovacche, albanesi e francesi), avevano inviato messaggi quelle sovietiche e cinesi, ci furono i saluti delle forze politiche e della Camera del Lavoro. Le delegate erano circa 300, di tutte le regioni esclusa la Basilicata. Quelle più numerose provenivano da Emilia, Toscana, Piemonte, Veneto e Lombardia. Le categorie più rappresentate erano le donne diplomate, laureate, professioniste e insegnanti, poi le casalinghe, le impiegate e le operaie. Molto scarse le contadine presenti, nonostante il ruolo da loro svolto nella Resistenza, prova di quanto le donne delle campagne fossero ancora prigioniere della povertà e della realtà familiare. Ma in molte mandarono doni commoventi, come le poche lire che possedevano o scarpe per chi poteva partecipare. Anche se si voleva che il Nord "non sopraffacesse il Sud", l’obiettivo non fu raggiunto.
Eppure la tragica esperienza degli anni di guerra aveva cambiato anche le donne del Sud, che non sarebbero potute diventare protagoniste della politica, come poi successe per la prima volta nella storia italiana. Nel Mezzogiorno tantissime donne semplici e illetterate, mentre figli e mariti erano su fronti lontani, avevano dovuto provvedere da sole alla famiglia, fuggire dalle città bombardate, abbandonare le loro case disastrate, adattarsi a vivere da sfollate e sinistrate.
Al 1° Congresso dell’UDI parlò emozionato il Presidente del Consiglio, Ferruccio Parri, accolto entusiasticamente. Le relazioni introduttive, sull’attività al Nord e su quella al Sud, furono svolte da Lucia Corti e Rita Montagnana, Maddalena Secco, Elvira Pajetta, Rosetta Longo, Rina Piccolato, Gemma Russo e molte altre. Il tema centrale del Congresso era - come l’ha definito Marisa Rodano - "inusuale e significativo": la proposta, sulla base dell’esperienza resistenziale delle donne, era di costituire un’associazione capace di rivolgersi a tutte le donne, indipendentemente dall’appartenenza o meno alle forze politiche, dalla condizione sociale e professionale, dal livello culturale, persino di quelle socialmente privilegiate. Questa era una prima fondamentale novità, rispetto alle forme associative che le donne storicamente si erano date nel nostro Paese, prima del fascismo, generalmente connotate dal riferimento alla professione o da obiettivi programmatici particolari come l’accesso all’istruzione, la lotta contro le leggi della regolamentazione della prostituzione di Stato o la richiesta del diritto di voto.
Vi era l’intuizione, anche se ciò non era detto esplicitamente, che vi fosse una differenza sostanziale tra uomini e donne, per cui non bastava che ad entrambi i sessi si riconoscessero eguali diritti; che le donne fossero portatrici, per la loro tradizione, il loro duplice impegno nel lavoro e nella famiglia, la loro aderenza ai problemi della vita quotidiana, di valori e competenze diverse da quelle della parte maschile della società; che, di conseguenza, fosse indispensabile chiamarle a impegnarsi per adeguare l’assetto sociale, per costruire istituzioni e politiche a misura di donne, oltreché di uomini. Operazione non facile - settant’anni fa - con la maggioranza delle donne casalinghe, senza redditi propri, con un’altissima percentuale di donne analfabete o che avevano frequentato la scuola elementare, soprattutto nel Mezzogiorno d’Italia. Le retribuzioni delle lavoratrici erano spesso la metà di quelle dei lavoratori che svolgevano lo stesso lavoro! Tra le lavoratrici prevalevano le donne impegnate in agricoltura che guadagnavano un terzo.
[...] Tornando alla fine della guerra, basta pensare all’azione dell’UDI nel Comitato Pro Voto per ottenere che le donne potessero votare, oppure a quella nel referendum monarchia/repubblica, o ancora per l’elezione dell’Assemblea Costituente, poi alla successiva campagna condotta dall’UDI per invitare le donne a votare. L’elenco di norme a favore delle donne da inserire nella Costituzione, che l’UDI sottopose il 26 giugno 1946 alle elette alla Costituente, era costituito da: "parità giuridica con gli uomini in ogni campo; riconoscimento del diritto al lavoro e accesso a tutte le scuole, professioni, carriere; diritto a un’adeguata protezione che permetta alla donna di adempiere ai suoi compiti di madre; uguale valutazione, trattamento e compenso degli uomini per uguale lavoro, rendimento, responsabilità". Tutte norme che effettivamente sono state poi introdotte nella Costituzione, mentre si rafforzavano le iniziative nella ricostruzione a favore dell’infanzia, per ottenere fondi per le colonie estive, per la casa agli sfollati e ai sinistrati e contro gli sfratti; a sostegno dei contadini che occupavano terre incolte o mal coltivate, contro l’uso delle armi da parte della polizia in servizio di ordine pubblico (furono raccolte 3 milioni di firme!), per la concessione della pensione alle donne del frusinate violentate dalle truppe coloniali francesi, sia per la riduzione del danno che come riconoscimento del reato dello stupro di guerra. Dopo la guerra l’associazione si concentra insomma sui problemi immediati o su battaglie di carattere generale. Anche nel referendum istituzionale, prendendo posizione per la repubblica, l’UDI pone tra i suoi punti programmatici la rinascita del Paese, per la difesa della famiglia e delle lavoratrici, e contro la discriminazione politica e sociale della donna con la lotta contro la prostituzione e l’analfabetismo, la riforma dei codici e la piena partecipazione delle donne alla vita amministrativa e politica.
A partire dal 1953, l’UDI dichiara che suo fine è la battaglia per l’emancipazione femminile, afferma la sua autonomia rispetto a governi, forze sociali, partiti politici e pone come suo obiettivo centrale il diritto delle donne al lavoro. Iniziano così le battaglie per la parità di salario, per la tutela delle lavoratrici madri e, anni dopo, per l’estensione di quelle stesse tutele alle lavoratrici autonome, artigiane, commercianti, per la tutela del lavoro a domicilio, per la pensione alle casalinghe, contro i licenziamenti a causa di matrimonio. Nel 1956 l’UDI comincia a definire la società come una società maschile e concentra l’attività sulla sua trasformazione e per lo sviluppo dei servizi sociali. Seguiranno le lotte per il Piano nazionale degli asili nido, la scuola materna pubblica, l’obbligo scolastico fino ai quindici anni, e per un nuovo diritto di famiglia basato sull’eguaglianza, con l’eliminazione delle norme del Codice Rocco. Bisogna ricordare che esistevano diverse norme per gli uomini e per le donne sul potere in famiglia (vis modica e ius corrigendi), sull’adulterio, sul delitto d’onore, sui figli nati fuori dal matrimonio, che erano definiti illegittimi. Lo stupro era un delitto contro la morale e non contro la persona, su questo sarà lanciata la legge di iniziativa popolare nel 1979. Poi arriveranno il divorzio, i consultori, la depenalizzazione dell’aborto, contro la violenza sessuale e la violenza in famiglia.
E le battaglie ancora in atto per continuare a costruire futuro e autodeterminazione, di fronte alle nuove sfide e alle nuove forme di dominio che ci sovrastano.
[NOTE]
1 F. Piva, Storia di Leda. Da bracciante a dirigente di partito, Franco Angeli Edizioni, Milano, 2009.
2 Testimonianza di B. Catini e S. Fontanesi in N. Caiti, R. Guarnieri, La memoria dei "rossi". Fascismo, Resistenza e Ricostruzione a Reggio Emilia, Ediesse, Roma, 1996, pp.126 e 406.
Vittoria Tola, Dalla Resistenza a protagoniste della Repubblica: la nascita dell’UDI in "Noi, compagne di combattimento…". I Gruppi di Difesa della Donna, 1943-1945, Il convegno e la ricerca, ANPI Nazionale, Torino, 2015