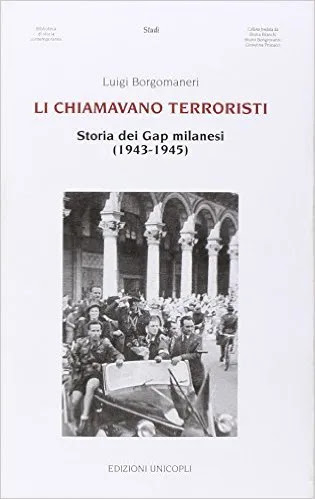Se le ragioni di questo vuoto consistessero nella mancanza di documentazione, il problema sarebbe già risolto, anche se non brillantemente: senza documenti, non si fa storia. Fortunatamente, per quanto riguarda le complesse vicende riguardanti costituzione, finalità, modalità operative, successi ed insuccessi dei Gap, i documenti ci sono, anche se non sempre di agevole consultazione. L’archivio del Partito comunista, che dei Gap fu il principale organizzatore, offre una notevole messe di documenti, spesso volutamente reticenti, o discontinui; intrecciati con le numerose autobiografie, ricordi e saggi di dirigenti e protagonisti, e integrati dalle fonti di polizia, rappresentano un buon punto di partenza per avviare una ricostruzione criticamente fondata della storia dei Gap. Dunque, le ragioni di un visibile vuoto storiografico non vanno cercate in questa direzione.
La spiegazione più ovvia, ma non per questo meno valida, è che si tratti di un argomento scomodo, affrontando il quale è difficile, anzi estremamente arduo, sottrarsi a giudizi di valore.
[...] Nessun democristiano o liberale ha mai condiviso, tanto meno dunque progettato o realizzato, la pratica degli attentati urbani; gli azionisti hanno in teoria approntato qualcosa di simile alle strutture gappiste, salvo utilizzarle quasi mai, o protestare con veemenza la loro estraneità agli attentati più clamorosi, su tutti naturalmente l’uccisione del filosofo Giovanni Gentile. In verità, nemmeno per il Partito comunista è stato facile reclutare e rendere operative le poche decine di gappisti indispensabili ad innescare la lotta armata nelle città occupate dell’autunno 1943; ancor più problematico fu sostituire la prima leva di gappisti, quasi tutti morti entro la primavera 1944: l’altissimo rischio della cattura, della tortura e della morte ebbe certo un ruolo non secondario accanto alle resistenze e perplessità di tipo etico nel rendere estremamente difficile trovare i combattenti disponibili ad entrare nei Gap.
A rendere problematico il superamento di reticenze e censure che hanno caratterizzato le autorapresentazioni del gappismo, oltre alle ragioni già ricordate, un forte contributo è stato fornito dall’offensiva antiresistenziale che a partire dal 1948 ha utilizzato proprio le questioni connesse all’uso della violenza, all’incerto statuto di legittimità nel quale i partigiani erano rimasti confinati, come armi giudiziarie e mediatiche per trasformare i combattenti in avventurieri sanguinari. In questa generale offensiva, i Gap, per molte intuibili ragioni, rappresentarono un argomento prediletto dai detrattori. Dai neofascisti degli anni cinquanta ai loro epigoni degli ultimi vent’anni, nei Gap si è voluto cogliere soprattutto, o esclusivamente, la responsabilità di suscitare feroci rappresaglie, cercate scientificamente dalla parte feroce, o cinica, della Resistenza.
Sia all’esaltazione acritica, sia alla demonizzazione, una ricostruzione del concreto, complicato e drammatico farsi dell’esperienza gappista non è mai parso un compito urgente e inderogabile.
A questo insieme di ragioni, già bastevoli, credo, a capire perché il gappismo sia argomento scomodo e poco frequentato dagli storici, andrà aggiunta almeno un’altra causa, tanto ovvia da poter essere anche solo accennata: il gappismo è stato rivendicato come il proprio antecedente legittimante da parte dei brigatisti degli anni settanta, fatto che ha naturalmente determinato un anatema sulla parola stessa. Terrorismo divenne sinonimo di follia omicida senza giustificazioni. Le stizzite e preoccupate precisazioni del Partito comunista tesero soprattutto a stabilire incommensurabili differenze fra le due epoche e i due fenomeni; ma come è noto, l’ansia autodifensiva non è mai una generosa levatrice di ricerche storiche, e così, ancor oggi il gappismo non è problema con il quale la storiografia della Resistenza si sia più misurata a fondo.
Santo Peli, I Gap nella Resistenza, SIM, 6 agosto 2015
Le città italiane del concitato triennio 1943-45 offrivano una serie di caratteristiche favorevoli per organizzare questo tipo di colpi: i bombardamenti delle forze Alleate rendevano impossibile stabilire i movimenti da e verso i centri urbani e gli sfollamenti impedivano alla neonata Repubblica Sociale Italiana (Rsi) e alle forze occupanti di controllare con efficacia l’ordine pubblico, nonostante gli sforzi profusi <4. In secondo luogo le città garantivano un vasto pubblico operaio, pronto, almeno secondo le convinzioni dei comunisti, a raccogliere l’esempio Gap e ad unirsi alle forze della Resistenza.
Per affrontare l’argomento dei Gap è doverosa una premessa: non è possibile parlare di gappismo senza tenere presente che ci troviamo di fronte ad esperienze eterogenee e assai difficilmente assimilabili; ogni Brigata Gap presenta peculiarità sociali, numeriche, di genere. In molti casi è legittimo domandarsi se queste esperienze siano tenute insieme solo dalla parola Gap e l’esempio più evidente di questa contraddizione è sicuramente il caso emiliano.
In Emilia il gappismo si sviluppò prevalentemente nelle campagne che circondavano le città e, a partire dalla primavera del 1944, la guerriglia in pianura assunse dimensioni tali da poter parlare di un vero e proprio esercito formato prevalentemente da contadini, mezzadri e braccianti, e da rappresentare una secca smentita a chi riteneva la pianura un luogo assolutamente non idoneo per combattere con i metodi della guerriglia <5.
Questa tipologia di lotta è assai diversa da quella che si sviluppò nei maggiori centri industriali del nord Italia (Milano, Torino, Genova) e ancora diversa da quella che si sviluppò in città liberate nella primavera-estate del 1944 (Roma e Firenze), dove il gappismo fu un fatto di pochi.
Il caso emiliano è dunque del tutto specifico e non può essere indicativo per altre realtà: l’appoggio e la partecipazione dei contadini alla lotta è una delle sue caratteristiche distintive. Le ragioni storiche dello straordinario sviluppo della Resistenza in queste zone vanno ricercate nella forte coscienza di classe dei contadini emiliani che si era consolidata attraverso le prime leghe cooperative ed attraverso un’avversione al fascismo che aveva radici ben più profonde di quelle fatte risalire all’8 settembre <6.
All’interno di quello che possiamo definire “gappismo di massa emiliano” si situa però anche la 7ª Gap bolognese che, per la sua caratteristica di agire in un contesto urbano più ampio, è da considerarsi ancora un caso a parte rispetto alle brigate Gap che agirono nei piccoli centri emiliani, i cui colpi furono architettati principalmente nei centri di prima periferia. La 7ª Brigata Gap arrivò a contare 24 squadre di gappisti, divisi tra Bologna ed il circondario bolognese, nella primavera-estate del 1944 <7. Alcide Leonardi, che assunse il comando proprio in quel periodo, riuscì ad imprimere un’efficacia straordinaria alla Brigata: nei centri di prima periferia vennero prese d’assalto le cabine telefoniche ed elettriche, le ferrovie, i tralicci dell’alta tensione e venne riposta molta attenzione all’attacco contro gli automezzi tedeschi, mentre nel centro cittadino non si allentò l’attività più strettamente terroristica. A partire dall’estate del 1944 vennero infatti messi in scena i colpi più clamorosi e spettacolari che presupponevano una grande forza numerica ed organizzativa e che hanno reso la Brigata bolognese un caso assolutamente unico: l’uccisione del vicefederale di Bologna (9 luglio), la bomba collocata al cinema Manzoni (20 luglio), la liberazione dei detenuti politici dal carcere di San Giovanni in Monte (9 agosto), i due attacchi all’hotel Baglioni (rispettivamente 29 settembre e 18 ottobre) e gli spericolati recuperi di armi portati a termine dalla squadra “Temporale” <8.
È quindi chiaro come sia difficile parlare di gappismo senza sottolineare che, in realtà, potremmo parlare di esperienze molto diverse tra loro in ragione del contesto urbano, sociale e politico: cercare di proporre una sintesi senza tenere conto dei diversi casi locali ci porterebbe ad una descrizione parziale e per certi versi anche fuorviante <9.
In generale la storia dei Gap si caratterizza per una difficoltà nel reclutamento e la loro entrata in azione venne più volte sollecitata dai comandi superiori che non si riuscivano a capacitare del cronico ritardo dell’organizzazione. Sia in fase iniziale che in fase inoltrata quando, in molti casi, interi nuclei di Gap caddero sotto i colpi delle delazioni e il lavoro dovette ricominciare da capo, il reclutamento fu assai arduo. Le difficoltà erano dovute ad una serie di fattori umani ed organizzativi. La percezione del forte rischio che si correva era un fattore da considerare: il gappista andava incontro ad una morte quasi certa e, per questo, molti scelsero di andare in montagna, dove in genere si combatteva una guerra più convenzionale, con più probabilità di fare ritorno a casa a liberazione avvenuta.
La peculiarità della lotta dei Gap erano infatti la clandestinità più assoluta e l’isolamento insieme, per i più, al distacco totale dalla famiglia e dagli ambienti frequentati prima di entrare a far parte della guerriglia. Nonostante ciò a Firenze le norme cospirative furono assai più fluide di quelle stabilite: il gruppo fondatore dei Gap proveniva da una banda di montagna, dove le precauzioni cospirative erano meno stringenti. I giovani reclutati avevano continuato a risiedere, anche dopo l’ingresso in clandestinità, nei rioni popolari di San Frediano e Santa Croce, dove erano molto conosciuti. Questi elementi fecero sì che a Firenze non si ebbero nemmeno i nomi di battaglia, se non come pure formalità <10.
Nelle memorie e nei diari pubblicati nel dopoguerra, ricorre con insistenza il tema di una guerra collettiva portata avanti nella solitudine. Carla Capponi descrive così la sensazione di liberazione quando le venne ordinato di abbandonare Roma per raggiungere Palestrina: "avevo riflettuto a lungo su quanto la lotta fosse diversa in città, per le strade e le piazze di Roma, dove ogni albero era un fortino tedesco e i fascisti giravano in branchi armati. Stare nascosti nella cantina di Duilio, vagare di notte per effettuare colpi di mano alle colonne tedesche in transito verso il fronte, girare armati sapendo che a ogni angolo potevi essere perquisito, arrestato, ucciso; conoscere i luoghi della tortura e persino i volti degli aguzzini e dei nemici che opprimevano la città: tutto questo ci aveva tenuti in una tensione continua. A Palestrina le cose erano diverse: la lotta armata si svolgeva a viso aperto e gli scontri, anche se impari, avvenivano a faccia a faccia con il nemico. Io mi sentivo serena, tranquilla nella coscienza di assolvere un dovere. Il gappista tende un agguato e non vede quasi mai le vittime del suo attacco, mentre il partigiano non solo vede in faccia il nemico ma ne vede anche la morte e ne deve seppellire il corpo per impedire conseguenze sulle popolazioni civili" <11.
La freddezza nell’affrontare la morte diventava determinante per chi doveva colpire in pieno giorno: era necessario saper disumanizzare il nemico, non preoccuparsi della sua vita, della sua famiglia, oppure del fatto che il milite in questione fosse o meno convinto della scelta intrapresa. Questo problema si poneva con meno prepotenza nella guerra in montagna dove era possibile affrontare la morte in maniera velata, come conseguenza inevitabile della guerra. La guerra in città poneva invece interrogativi sulla vita e soprattutto sulla morte non eludibili; la morte doveva essere guardata in faccia con meno mediazioni, anche culturali: il gappista dopo aver sparato ripiombava nella solitudine dato che con i compagni di lotta raramente poteva condividere impressioni o titubanze per non contravvenire alle norme cospirative.
Un altro elemento che ritroviamo nei diari e nelle memorie dei gappisti è la difficoltà iniziale ad eseguire gli ordini imposti dal comando di agire subito e di colpire “uomini vivi”. Rompere questo digiuno delle armi fu per molti una scelta sofferta, difficile, ricordata con una sensazione di profondo malessere: "Ma noi non riuscivamo a dimenticare che le nostre armi avevano fatto fuoco su uomini vivi. Li avevamo visti. […] Avevo sparato su un uomo. Non riuscivo a parlare, a mescolarmi di nuovo con i miei amici. Ormai tra me e loro era avvenuta una rottura decisiva: io avevo cominciato la guerriglia. […] Io me ne rimasi solo, sveglio, a pensare. Mi domandavo mille volte se un uomo aveva il diritto di colpire un altro uomo. A una domanda così semplicistica mi rispondevo mille volte di no. Ma la mia guerra era legittima, e soprattutto non l’avevo voluta io, né gli uomini della mia parte. Eravamo stati travolti da un mare di violenza, cercavamo di difenderci da essa e di salvare quanto fosse più possibile dallo sfacelo" <12.
[NOTE]
4 Cfr. L. Paggi, Il «popolo dei morti». La repubblica italiana nata dalla guerra (1940-1946), il Mulino, Bologna 2009, pp. 110-116.
5 Cfr. M. Conti, Guerra in pianura. I Gruppi di azione patriottica (Gap) a Reggio Emilia, «RSRicerche Storiche», 118 (2014).
6 Cfr. D. Gagliani, Culture comuniste tra anni ’30 e ’40: Togliatti e Reggio “rossa”, alcune note, in G. Boccolari, L. Casali (a cura di), I Magnacucchi, Valdo Magnani e la ricerca di una sinistra autonoma e democratica, Feltrinelli, Milano 1991, pp. 25-46; L. Casali, D. Gagliani, Presenza comunista, lotta armata e lotta sociale nelle relazioni degli «ispettori»: settembre 1943-marzo 1944, in L. Arbizzani (a cura di), Azione operaia, contadina, di massa, in L’Emilia Romagna nella guerra di Liberazione, vol. III, De Donato, Bari 1976, pp. 499-611.
7 Istituto per la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea di Reggio Emilia (d’ora in poi ISTORECO), Fondo Archivi della Resistenza (d’ora in poi AR), b. 1b, fasc. 18, Delegazione per l’Emilia del comando generale dei distaccamenti e Brigate d’Assalto Garibaldi, giugno 1944.
8 Per una sintesi del caso bolognese cfr. M. De Micheli, 7ª Gap, Editori Riuniti, Roma 1971.
9 Il recente libro di Santo Peli, Storie di Gap. Terrorismo urbano e resistenza, del quale abbiamo preso visione solo a lavoro ultimato, restituisce per la prima volta una sintesi dell’esperienza dei Gap attraverso un’avvincente ricostruzione dei colpi più rappresentativi. L’autore chiarisce che la scelta del plurale “storie di Gap” in luogo del singolare “storia dei Gap” è tesa a delimitare i confini della sua ricerca che, non potendosi basare su una mole di studi locali criticamente fondati - tuttora assenti -, ha dovuto comprendere solo i casi ritenuti esemplari ed emblematici. Cfr. S. Peli, Storie di Gap. Terrorismo urbano e resistenza, Torino, Einaudi 2014, p. 8.
10 A. Fagioli, Partigiano a 15 anni, Alfa, Firenze 1993, p. 106.
11 Carla Capponi, Con cuore di donna, il Saggiatore, Milano 2000, pp. 277-278; cfr. anche R. Bentivegna, Senza fare di necessità virtù. Memorie di un antifascista, a cura di M. Ponzani, Einaudi, Torino 2011, pp. 110-111.
12 Cfr. R. Bentivegna, Achtung Banditen! Roma 1944, Mursia, Milano 1983, pp. 82-83.
Mariachiara Conti, Resistere in città: i Gruppi di azione patriottica, alcune line di ricerca in Aa.Vv., Fronte e fronte interno. Le guerre in età contemporanea - II. La seconda guerra mondiale e altri conflitti, Percorsi Storici - Rivista di storia contemporanea, 3 (2015)