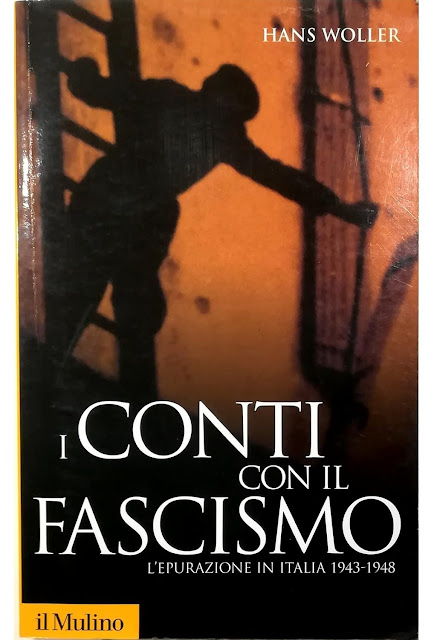Le montagne dell'Ossola, le colline del Monferrato, le Langhe, la Val Borbera, l'Oltrepo pavese sono tutti luoghi che hanno vissuto una propria e caratterizzante storia resistenziale, oggi di facile ricostruzione e lettura.
Per le città, ciò difficilmente avviene.
Valenza ne è prova. Una città, organizzata e viva, porta con sé un patrimonio di relazioni fra istituzioni, fra poteri pubblici, centri di riferimento economico e sociale.
Negli anni 30'- 40' Valenza, pur in presenza dell'autarchia di Regime, era legata a filo doppio con Alessandria e Casale Monferrato; sviluppava relazioni con la Lomellina, con Pavia e Milano, con Genova e Torino.
Le vie di comunicazione stradale e ferroviaria erano adeguate, poste a raggiera, con frequenti intersezioni verso Milano, Torino e Genova; il Po fungeva da confine fisico fra Piemonte e Lombardia, ma anche da via di traffico e comunicazione naturale.
Le aziende orafe e calzaturiere alimentavano traffici a dimensione più ampia, oltre i confini italiani; i gerarchi fascisti erano correlati al capoluogo provinciale e da qui verso Torino e Roma; le scuole servivano parecchi paesi limitrofi, con scambi di culture fra contadini, operai, artigiani, imprenditori; il Regime aveva da decenni promosso ed organizzato il consenso, con tutte le varie iniziative di proselitismo e indottrinamento.
Era una città articolata, fatta di vissuto diverso, una città aperta e geograficamente polarizzante.
Furono proprio questi fattori a far decidere gli occupanti tedeschi a scegliere Valenza come centro per collocarvi comandi di polizia, squadre di milizie SS, sezione SD Sicherheit Dienst, militari della Wehrmacht, l'organizzazione Todt, la Zugleitung, postazioni di contraerea della Flak, gruppi di genio pontieri.
La presenza tedesca si rafforzò, dopo che Alessandria divenne sempre più frequente bersaglio dei bombardamenti alleati.
A Valenza venne trasferito il comando provinciale delle truppe tedesche. Non solo, vennero intensificati tutti i controlli sulle vie di comunicazione, sulla rete ferroviaria, sul fiume Po, ad ogni attracco di barche e sui vari ponti di attraversamento fra Trino, Casale e Valenza.
In questo contesto va collocata la storia resistenziale di Valenza, una città occupata dai tedeschi perchè ritenuta strategica, una città cerniera fra due regioni, una città sotto il dominio capillare della K 1014 Kommandantur e l'ausilio delle rinate presenze repubblichine, con comandi della G.N.R. e Brigate Nere.
Pur in questo difficile contesto, sorsero le formazioni GAP (gruppi di azione patriottica) di Enzo Luigi Guidi, detto Batista; poi alcune esperienze di SAP (squadre di azione patriottica); la componente comunista, come in passato era stata fattore determinante dell'antifascismo locale unitamente alla matrice socialista, costituì una significativa ispirazione per le formazioni partigiane; venne ricostituita la sezione del PCI, mix di militanza politica ed ideologica.
I distaccamenti Rasinone e Paradiso, il gruppo di Ticineto-Valmacca della Garibaldi, vissero fasi diverse di organizzazione, in crescendo per adesioni ed efficacia. Si affermarono, inoltre, le formazioni GL Paolo Braccini con la brigata Pasino, al comando di Carlo Garbarino fra San Salvatore e Castelletto Monferrato; con la brigata Lenti al comando di Filippo Callori nell'area di Vignale.
Operarono, inoltre, la Divisione Matteotti-Marengo Borgo Po, tra Valle San Bartolomeo-Filippona-Lobbi; la Divisione Patria fra Occimiano-Mirabello-Giarole; la brigata 108 Paolo Rossi della Garibaldi, con il distaccamento nell'area di Bassignana-Fiondi-Pecetto-Grava-Mugarone <1
Attorno a Valenza, mese dopo mese, venne creata una rete capillare ed efficace di dissenso operativo. Le formazioni partigiane si impegnarono in consistenti azioni di sabotaggio e danneggiamento verso i posti di blocco e controllo dei nazifascisti; ospitarono e nascosero per mesi i prigionieri alleati inglesi, americani, australiani, neozelandesi liberati dai campi di concentramento-prigionia del Piemonte e Lombardia e dal Forte di Gavi.
La stazione e la galleria ferroviaria fra Valenza e Valmadonna costituirono per mesi l'obiettivo di furti, saccheggi da parte delle formazioni partigiane.
Sull'arteria ferroviaria, infatti, i tedeschi fecero transitare armi e viveri verso altre località lombarde e piemontesi, per evitare i frequenti bombardamenti alleati su Alessandria.
In alcune circostanze, i partigiani nascosero le armi e munizioni saccheggiate ai tedeschi proprio all'interno della galleria di Valmadonna.
Le formazioni GAP attaccarono a più riprese le postazioni tedesche; le azioni di sabotaggio sono ampiamente documentate e citate in numerosi dispacci e fonogrammi che i tedeschi inviavano giornalmente ai comandi superiori, fonogrammi rinvenuti recentemente, tradotti e pubblicati nel volume "Resistenza e nuova coscienza civile" a cura dell'autore.
I comandi tedeschi giunsero a comminare multe salatissime ai comuni del Valenzano per disincentivare le attività di sabotaggio. Le multe dovevano essere pagate al comando tedesco di Valenza. I tedeschi non solo occuparono il territorio, ma inflissero sanzioni per punire le azioni di dissenso delle popolazioni.
Gli esordi, il CLN, una città controllata dai tedeschi.
La caduta di Mussolini del 25 luglio e l’armistizio dell' 8 settembre 1943 rialimentarono le convinzioni e le speranze per la libertà, anche a Valenza. Durante il ventennio fascista, il dissenso esplicito venne rappresentato, in modo efficace, dal socialista Francesco Boris, già capostazione. Non aderì al Fascio, dovette cercarsi un altro lavoro. Le organizzazioni comuniste, pur nell'omologazione dissuasiva del Fascio, tennero vivo il pensiero antifascista attraverso cellule di militanti. A Valenza era operativa una sezione comunista a tutti gli effetti, con riferimenti organici con Alessandria e Torino.
Anche nelle file cattoliche, si costituì nel ’42 la prima sezione della DC, d’ispirazione degasperiana. Nel laboratorio della farmacia Manfredi, alla presenza dell’ex popolare avv. Giuseppe Brusasca, venne fondata la sezione. Contribuirono Carlo Barberis, Gigi Venanzio Vaggi, Luigi e Vittorio Manfredi, Pietro Staurino, Luigi Deambroggi, Luigi Stanchi, Giuseppe Bonelli e Felice Cavalli. La sezione sviluppò immediatamente temi ed iniziative di dissenso clandestino al regime.
Alla notizia dell’arresto di Mussolini, nell’abitazione di Francesco Boris, si tenne un primo incontro per costituire il CLN valenzano. Accanto a Boris per il partito socialista, vi aderirono Luigi Vaggi per la DC, Ercole Morando per il PCI, Vittorio Carones per il Partito d’Azione e Poggio per il PLI, poi sostituito da Barberis detto Cuttica.
Il CLN di Valenza tenne varie riunioni, cambiando sede di volta in volta, per non destare sospetti. Si svolsero a casa Boris, a casa di Costantino Scalcabarozzi, in casa Mazza alle Terme di Monte Valenza, a casa dei fratelli Marchese, nella biblioteca Silvio Pellico dell’oratorio del Duomo di Valenza. <2
Francesco Boris e Paolo De Michelis (già parlamentare socialista negli anni ’20) furono arrestati a marzo 1944 e condotti nella sezione tedesca delle Carceri Nuove a Torino, per poi essere inviati nei campi in Germania. Vennero poi liberati, grazie ad uno scambio di prigionieri.
Il 16 gennaio 1944, il ventenne Sandro Pino venne colpito a morte in occasione di una perquisizione e retata della G.N.R. nel bar Achille, nel pieno centro, alla caccia di antifascisti e ribelli. Il fatto destò grande sconcerto ed intimorì i giovani. Giulio Doria, antifascista ed aderente a metà ’44 al movimento partigiano, ricorda dettagliatamente quei difficili momenti nell’intervista rilasciata a Maria Grazia Molina e pubblicata nel n. 23 di “Valenza d’na vota” edito a dicembre 2008. Il fratello di Giulio, Mario, aderì subito alla formazione autonoma Patria, guidata da Edoardo Martino e Giovanni Sisto. Il secondo fratello, Pietro, visse anni di prigionia in Germania, come militare catturato dai tedeschi. Giulio disertò la chiamata alla Capitaneria di Savona e si diede alla macchia, nella campagna valenzana. Giulio ricorda d’aver curato e nascosto cinque militari australiani, sfuggiti alla cattura dei tedeschi; di averli poi avviati in Lombardia. Anche Giulio entrò nella brigata autonoma Patria, si collegò con Vaggi e tesse una fitta rete di relazioni fra la città ed i comuni del Monferrato.
La presenza strutturata dei tedeschi occupanti cambiò il volto alla città. I liberi movimenti erano impossibili; le truppe tedesche, coadiuvate ed indirizzate dai fascisti repubblichini, erano pervasive. Vennero organizzati frequenti posti di blocco sulle vie di accesso, sulle arterie di comunicazione verso Pavia, Alessandria, Casale Monferrato, Tortona. La ferrovia era super controllata, perchè utilizzata spesso dai tedeschi per il trasferimento di esplosivi ed armi. Dopo i ripetuti bombardamenti alleati al ponte di ferro sul fiume Po, i tedeschi organizzarono attracchi per traghetti, sui quali transitavano truppe, armi e munizioni verso Milano.
Il 17 febbraio 1944, il 10 dicembre 1944 ed il 2 marzo 1945 si ebbero a Valenza rastrellamenti intensi e radicali, con minuziose perquisizioni ad intere vie ed isolati, arresti di giovani.
L' attività della missione americana Youngstown. Inediti dall'archivio di Gian Carlo Ratti
Una precisa conferma dell'organizzazione militare e logistica tedesca, delle forze partigiane operanti nel Monferrato e nel Valenzano, ci viene dall'inedito e significativo materiale documentale presente nell'archivio Gian Carlo Ratti, ora in consegna all'autore, di prossimo commento e pubblicazione. <3 L'archivio è costituito da un dettagliato memoriale, da ampia documentazione in originale, da mappe, appunti, manoscritti, rapporti, note di guerra, attestati, fonogrammi [...]
Per le città, ciò difficilmente avviene.
Valenza ne è prova. Una città, organizzata e viva, porta con sé un patrimonio di relazioni fra istituzioni, fra poteri pubblici, centri di riferimento economico e sociale.
Negli anni 30'- 40' Valenza, pur in presenza dell'autarchia di Regime, era legata a filo doppio con Alessandria e Casale Monferrato; sviluppava relazioni con la Lomellina, con Pavia e Milano, con Genova e Torino.
Le vie di comunicazione stradale e ferroviaria erano adeguate, poste a raggiera, con frequenti intersezioni verso Milano, Torino e Genova; il Po fungeva da confine fisico fra Piemonte e Lombardia, ma anche da via di traffico e comunicazione naturale.
Le aziende orafe e calzaturiere alimentavano traffici a dimensione più ampia, oltre i confini italiani; i gerarchi fascisti erano correlati al capoluogo provinciale e da qui verso Torino e Roma; le scuole servivano parecchi paesi limitrofi, con scambi di culture fra contadini, operai, artigiani, imprenditori; il Regime aveva da decenni promosso ed organizzato il consenso, con tutte le varie iniziative di proselitismo e indottrinamento.
Era una città articolata, fatta di vissuto diverso, una città aperta e geograficamente polarizzante.
Furono proprio questi fattori a far decidere gli occupanti tedeschi a scegliere Valenza come centro per collocarvi comandi di polizia, squadre di milizie SS, sezione SD Sicherheit Dienst, militari della Wehrmacht, l'organizzazione Todt, la Zugleitung, postazioni di contraerea della Flak, gruppi di genio pontieri.
La presenza tedesca si rafforzò, dopo che Alessandria divenne sempre più frequente bersaglio dei bombardamenti alleati.
A Valenza venne trasferito il comando provinciale delle truppe tedesche. Non solo, vennero intensificati tutti i controlli sulle vie di comunicazione, sulla rete ferroviaria, sul fiume Po, ad ogni attracco di barche e sui vari ponti di attraversamento fra Trino, Casale e Valenza.
In questo contesto va collocata la storia resistenziale di Valenza, una città occupata dai tedeschi perchè ritenuta strategica, una città cerniera fra due regioni, una città sotto il dominio capillare della K 1014 Kommandantur e l'ausilio delle rinate presenze repubblichine, con comandi della G.N.R. e Brigate Nere.
Pur in questo difficile contesto, sorsero le formazioni GAP (gruppi di azione patriottica) di Enzo Luigi Guidi, detto Batista; poi alcune esperienze di SAP (squadre di azione patriottica); la componente comunista, come in passato era stata fattore determinante dell'antifascismo locale unitamente alla matrice socialista, costituì una significativa ispirazione per le formazioni partigiane; venne ricostituita la sezione del PCI, mix di militanza politica ed ideologica.
I distaccamenti Rasinone e Paradiso, il gruppo di Ticineto-Valmacca della Garibaldi, vissero fasi diverse di organizzazione, in crescendo per adesioni ed efficacia. Si affermarono, inoltre, le formazioni GL Paolo Braccini con la brigata Pasino, al comando di Carlo Garbarino fra San Salvatore e Castelletto Monferrato; con la brigata Lenti al comando di Filippo Callori nell'area di Vignale.
Operarono, inoltre, la Divisione Matteotti-Marengo Borgo Po, tra Valle San Bartolomeo-Filippona-Lobbi; la Divisione Patria fra Occimiano-Mirabello-Giarole; la brigata 108 Paolo Rossi della Garibaldi, con il distaccamento nell'area di Bassignana-Fiondi-Pecetto-Grava-Mugarone <1
Attorno a Valenza, mese dopo mese, venne creata una rete capillare ed efficace di dissenso operativo. Le formazioni partigiane si impegnarono in consistenti azioni di sabotaggio e danneggiamento verso i posti di blocco e controllo dei nazifascisti; ospitarono e nascosero per mesi i prigionieri alleati inglesi, americani, australiani, neozelandesi liberati dai campi di concentramento-prigionia del Piemonte e Lombardia e dal Forte di Gavi.
La stazione e la galleria ferroviaria fra Valenza e Valmadonna costituirono per mesi l'obiettivo di furti, saccheggi da parte delle formazioni partigiane.
Sull'arteria ferroviaria, infatti, i tedeschi fecero transitare armi e viveri verso altre località lombarde e piemontesi, per evitare i frequenti bombardamenti alleati su Alessandria.
In alcune circostanze, i partigiani nascosero le armi e munizioni saccheggiate ai tedeschi proprio all'interno della galleria di Valmadonna.
Le formazioni GAP attaccarono a più riprese le postazioni tedesche; le azioni di sabotaggio sono ampiamente documentate e citate in numerosi dispacci e fonogrammi che i tedeschi inviavano giornalmente ai comandi superiori, fonogrammi rinvenuti recentemente, tradotti e pubblicati nel volume "Resistenza e nuova coscienza civile" a cura dell'autore.
I comandi tedeschi giunsero a comminare multe salatissime ai comuni del Valenzano per disincentivare le attività di sabotaggio. Le multe dovevano essere pagate al comando tedesco di Valenza. I tedeschi non solo occuparono il territorio, ma inflissero sanzioni per punire le azioni di dissenso delle popolazioni.
Gli esordi, il CLN, una città controllata dai tedeschi.
La caduta di Mussolini del 25 luglio e l’armistizio dell' 8 settembre 1943 rialimentarono le convinzioni e le speranze per la libertà, anche a Valenza. Durante il ventennio fascista, il dissenso esplicito venne rappresentato, in modo efficace, dal socialista Francesco Boris, già capostazione. Non aderì al Fascio, dovette cercarsi un altro lavoro. Le organizzazioni comuniste, pur nell'omologazione dissuasiva del Fascio, tennero vivo il pensiero antifascista attraverso cellule di militanti. A Valenza era operativa una sezione comunista a tutti gli effetti, con riferimenti organici con Alessandria e Torino.
Anche nelle file cattoliche, si costituì nel ’42 la prima sezione della DC, d’ispirazione degasperiana. Nel laboratorio della farmacia Manfredi, alla presenza dell’ex popolare avv. Giuseppe Brusasca, venne fondata la sezione. Contribuirono Carlo Barberis, Gigi Venanzio Vaggi, Luigi e Vittorio Manfredi, Pietro Staurino, Luigi Deambroggi, Luigi Stanchi, Giuseppe Bonelli e Felice Cavalli. La sezione sviluppò immediatamente temi ed iniziative di dissenso clandestino al regime.
Alla notizia dell’arresto di Mussolini, nell’abitazione di Francesco Boris, si tenne un primo incontro per costituire il CLN valenzano. Accanto a Boris per il partito socialista, vi aderirono Luigi Vaggi per la DC, Ercole Morando per il PCI, Vittorio Carones per il Partito d’Azione e Poggio per il PLI, poi sostituito da Barberis detto Cuttica.
Il CLN di Valenza tenne varie riunioni, cambiando sede di volta in volta, per non destare sospetti. Si svolsero a casa Boris, a casa di Costantino Scalcabarozzi, in casa Mazza alle Terme di Monte Valenza, a casa dei fratelli Marchese, nella biblioteca Silvio Pellico dell’oratorio del Duomo di Valenza. <2
Francesco Boris e Paolo De Michelis (già parlamentare socialista negli anni ’20) furono arrestati a marzo 1944 e condotti nella sezione tedesca delle Carceri Nuove a Torino, per poi essere inviati nei campi in Germania. Vennero poi liberati, grazie ad uno scambio di prigionieri.
Il 16 gennaio 1944, il ventenne Sandro Pino venne colpito a morte in occasione di una perquisizione e retata della G.N.R. nel bar Achille, nel pieno centro, alla caccia di antifascisti e ribelli. Il fatto destò grande sconcerto ed intimorì i giovani. Giulio Doria, antifascista ed aderente a metà ’44 al movimento partigiano, ricorda dettagliatamente quei difficili momenti nell’intervista rilasciata a Maria Grazia Molina e pubblicata nel n. 23 di “Valenza d’na vota” edito a dicembre 2008. Il fratello di Giulio, Mario, aderì subito alla formazione autonoma Patria, guidata da Edoardo Martino e Giovanni Sisto. Il secondo fratello, Pietro, visse anni di prigionia in Germania, come militare catturato dai tedeschi. Giulio disertò la chiamata alla Capitaneria di Savona e si diede alla macchia, nella campagna valenzana. Giulio ricorda d’aver curato e nascosto cinque militari australiani, sfuggiti alla cattura dei tedeschi; di averli poi avviati in Lombardia. Anche Giulio entrò nella brigata autonoma Patria, si collegò con Vaggi e tesse una fitta rete di relazioni fra la città ed i comuni del Monferrato.
La presenza strutturata dei tedeschi occupanti cambiò il volto alla città. I liberi movimenti erano impossibili; le truppe tedesche, coadiuvate ed indirizzate dai fascisti repubblichini, erano pervasive. Vennero organizzati frequenti posti di blocco sulle vie di accesso, sulle arterie di comunicazione verso Pavia, Alessandria, Casale Monferrato, Tortona. La ferrovia era super controllata, perchè utilizzata spesso dai tedeschi per il trasferimento di esplosivi ed armi. Dopo i ripetuti bombardamenti alleati al ponte di ferro sul fiume Po, i tedeschi organizzarono attracchi per traghetti, sui quali transitavano truppe, armi e munizioni verso Milano.
Il 17 febbraio 1944, il 10 dicembre 1944 ed il 2 marzo 1945 si ebbero a Valenza rastrellamenti intensi e radicali, con minuziose perquisizioni ad intere vie ed isolati, arresti di giovani.
L' attività della missione americana Youngstown. Inediti dall'archivio di Gian Carlo Ratti
Una precisa conferma dell'organizzazione militare e logistica tedesca, delle forze partigiane operanti nel Monferrato e nel Valenzano, ci viene dall'inedito e significativo materiale documentale presente nell'archivio Gian Carlo Ratti, ora in consegna all'autore, di prossimo commento e pubblicazione. <3 L'archivio è costituito da un dettagliato memoriale, da ampia documentazione in originale, da mappe, appunti, manoscritti, rapporti, note di guerra, attestati, fonogrammi [...]
[NOTE]
1 Si vedano i saggi: "Valenza antifascista e partigiana" di Enzo Luigi Guidi, edito nel 1981 dall'ANPI di Valenza; "Resistenza e nuova coscienza civile" di Sergio Favretto, edito da Falsopiano nel 2009; "La Provincia di Alessandria nella Resistenza" di William Valsesia, edito nel 1980; "Una brigata di pianura, cronaca della 108° brigata Garibaldi Paolo Rossi" di O. Mussio, edito dall'ANPI di Castelnuovo Scrivia, nel 1976.
2 Questi avvenimenti sono descritti nel volume "Resistenza e nuova coscienza civile" di Sergio Favretto, edito da Falsopiano nel 2009
3 L'archivio Ratti è stato solo recentemente consegnato in esame e custodia all'autore. Si presenta, già a primo acchito, come una fonte significativa di documentazione inedita. Per il 2013 si presume possa costituire la fonte di nuove analisi storiche e possa essere ospitato in alcune pubblicazioni sui temi resistenziali del Piemonte.
Sergio Favretto, La Resistenza nel Valenzano. L'eccidio della Banda Lenti, Comune di Valenza (AL), 2012
1 Si vedano i saggi: "Valenza antifascista e partigiana" di Enzo Luigi Guidi, edito nel 1981 dall'ANPI di Valenza; "Resistenza e nuova coscienza civile" di Sergio Favretto, edito da Falsopiano nel 2009; "La Provincia di Alessandria nella Resistenza" di William Valsesia, edito nel 1980; "Una brigata di pianura, cronaca della 108° brigata Garibaldi Paolo Rossi" di O. Mussio, edito dall'ANPI di Castelnuovo Scrivia, nel 1976.
2 Questi avvenimenti sono descritti nel volume "Resistenza e nuova coscienza civile" di Sergio Favretto, edito da Falsopiano nel 2009
3 L'archivio Ratti è stato solo recentemente consegnato in esame e custodia all'autore. Si presenta, già a primo acchito, come una fonte significativa di documentazione inedita. Per il 2013 si presume possa costituire la fonte di nuove analisi storiche e possa essere ospitato in alcune pubblicazioni sui temi resistenziali del Piemonte.
Sergio Favretto, La Resistenza nel Valenzano. L'eccidio della Banda Lenti, Comune di Valenza (AL), 2012
Tra le pubblicazioni di Sergio Favretto: Beppe Fenoglio. Il riscatto della libertà, Falsopiano, 2023; Quando l'arte incontra il diritto. Autenticità e inquietudini del mercato, Giappichelli, 2022; Partigiani del mare. Antifascismo e Resistenza sul confine ligure-francese, Seb27, Torino, 2022; Il papiro di Artemidoro: verità e trasparenza nel mercato dei beni culturali e delle opere d’arte, LineLab, Alessandria, 2020; Con la Resistenza. Intelligence e missioni alleate sulla costa ligure, Seb27, Torino, 2019; Un carabiniere, testimone di storia. Mussolini a Ponza e a la Maddalena narrato in un diario, Arti grafiche, 2017; Una trama sottile. Fiat, fabbrica, missioni alleate e Resistenza, Seb27, 2017; Coraggio e passione. Riccardo Coppo, il sindaco, le sfide, Falsopiano, 2017; Fenoglio verso il 25 aprile. Narrato e vissuto in Ur Partigiano Johnny, Falsopiano, 2015; Resistenza e nuova coscienza civile. Fatti e protagonisti nel Monferrato casalese, Falsopiano, 2009; Il diritto a braccetto con l'arte, Falsopiano, 2007; Giuseppe Brusasca: radicale antifascismo e servizio alle istituzioni, Atti convegno di studi a Casale Monferrato, maggio 2006; I nuovi Centri per l’Impiego fra sviluppo locale e occupazione (con Daniele Ciravegna e Mario Matto), Franco Angeli, 2000; Casale Partigiana: fatti e personaggi della resistenza nel Casalese, Libertas Club, 1977
Adriano Maini
Adriano Maini